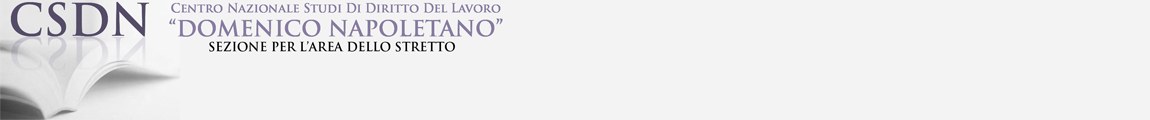LICENZIAMENTI INDIRETTI
L’esame della fattispecie dei licenziamenti collettivi non può prescindere dall’analisi e dall’identificazione – alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale sia interno che eurounitario – dei presupposti in presenza dei quali sia possibile ricomprendere anche i “licenziamenti indiretti” nel numero minimo di cinque licenziamenti, considerato come sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.
Il riferimento normativo da cui prendere le mosse è l’art. 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a, della Direttiva CE 98/59 del 20.07.1998, che definisce la nozione di licenziamento collettivo come ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è pari alle soglie numeriche colà di seguito indicate;
mentre il dato giurisprudenziale di riferimento è la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 novembre 2015, resa in causa C-422/14, nel procedimento Pujante Rivera, che aveva vagliato la fattispecie di un lavoratore spagnolo che, in ragione del rifiuto della riduzione della propria retribuzione fissa in misura pari al 25% – imposta unilateralmente dal datore di lavoro per ragioni di ordine economico e produttivo – aveva concordato una risoluzione consensuale del contratto di lavoro, accompagnata dal percepimento di un’indennità.
Orbene, secondo la Corte, la cessazione di quel contratto era da
qualificarsi come “licenziamento” ai sensi dell’art.1, paragrafo 1, primo comma, lettera a, della Direttiva menzionata, inteso quale azione di un datore di lavoro che proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso e, in quanto tale, da ricondurre nell’alveo del numero minimo di licenziamenti necessari ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo;
un caso, dunque, quello esaminato dalla Corte, in cui si giunge, sì, ad una risoluzione che, prima facie, potrebbe configurarsi come consensuale, ma che, in esito all’esame complessivo, non può che imputarsi alla intervenuta modifica unilaterale di parte datoriale (p. 50 sent. cit).[1]
E, a queste conclusioni, la Corte è pervenuta sulla scorta del dichiarato intento della Direttiva ricavabile dal suo preambolo (in particolare, dal Considerando 2 e 6), che è quello di rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi e di realizzare un mercato interno che porti ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nei vari Stati membri: del resto, continua la Corte, una diversa e più stringente interpretazione data ad una risoluzione del rapporto di tal fatta, altererebbe l’ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena efficacia.
Ora, sino all’anno 2020, la nostra giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. Civ. 29 marzo 2010 n. 7519), formatasi in relazione all’art. 24 della L. 23.07.1991 n.223, aveva reiteratamente affermato come il termine licenziamento andasse inteso in senso strettamente tecnico sicché nel numero minimo di cinque licenziamenti, considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero essere incluse altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero state riconducibili all’iniziativa del datore di lavoro, posta in essere nell’ambito di una medesima operazione di riduzione della forza lavoro.
Nel solco di questo precedente orientamento di legittimità, poi superato con l’ordinanza 20.07.2020 n. 15401 (su cui meglio si argomenterà infra), meritano di essere ricordate le pronunce
22.01.2007 n. 1334 e 25.10.2000 n. 14079, perché nelle rispettive articolate motivazioni, la Corte di Cassazione dà conto delle analitiche ragioni di detta interpretazione restrittiva [2]; in particolare, la Corte (sent. n.14079/2000) aveva respinto il ricorso con il quale il lavoratore aveva lamentato che le molteplici fattispecie estintive registrate nel periodo antecedente il suo licenziamento esprimevano, in realtà, l’inequivoca intenzione di procedere a non meno di cinque licenziamenti; circostanza, questa, che avrebbe imposto il rispetto delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 24 L.223/1991, dovendosi, indi, qualificare il licenziamento intervenuto nei suoi confronti come il frammento di una procedura collettiva illegittimamente espletata [3].
Decisioni, queste, degne di nota perché, muovendo dal rapporto
tra Direttiva comunitaria n.98/59 e legislazione italiana, hanno posto in evidenza come la nostra normativa interna, con la previsione di cui all’art. 24 della L. 223/1991 – di cinque licenziamenti ai fini della qualificazione di un licenziamento come collettivo – aveva accordato ai lavoratori una tutela molto più ampia rispetto a quella comunitaria che prevede, invece, il numero di almeno dieci quale soglia minima.
Logico corollario, dunque, di queste premesse era che, ai fini dell’identificazione di un licenziamento collettivo e, indi, ai fini dell’applicazione della L. 223/1991, all’interno della detta soglia minima, avrebbero dovuto necessariamente essere considerati solamente i licenziamenti in senso tecnico intimati dal datore di lavoro.
Ora, solo con l’ordinanza n. 15401 del 20 luglio 2020, la nostra Corte di Cassazione si è espressamente posta in posizione di esplicito “superamento” del precedente consolidato orientamento e ciò ha fatto nel precipuo intento di conformarsi all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza Pujante Rivera.
La Suprema Corte, in quell’occasione, aveva preso le mosse da una sentenza (n.909/2017) resa dalla Corte di Appello di Milano che aveva esaminato l’impugnazione di un lavoratore avverso il proprio licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e che lamentava il mancato computo – ai fini del raggiungimento del numero minimo di licenziamenti necessari ad esperire la procedura di cui all’art.24 L.223/1991 – nel periodo dei c.d. giorni profilo, anche della cessazione del rapporto di una lavoratrice, per il suo rifiuto ad essere trasferita, e di “alcune…risoluzioni consensuali” (a seguito di procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966) derivanti “dalla mancata accettazione di un trasferimento“; ciò che, a dire del ricorrente, avrebbe determinato il superamento del limite del numero di licenziamenti necessari a fare configurare il licenziamento come collettivo.
La Corte territoriale ribadiva che “anche a voler ricondurre le suddette fattispecie ad un effettivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, il requisito minimo dei 5 licenziamenti non sarebbe stato comunque raggiunto atteso che il requisito minimo richiesto dalla norma (art. 24 Legge 223/1991) è un licenziamento che trovi la sua matrice giustificativa in un motivo oggettivo, ovvero nella riduzione o trasformazione della forza lavoro, e, in quest’ottica, ai fini del computo del licenziamento collettivo, non poteva attribuirsi rilevanza alcuna alle risoluzioni aventi alla base diversa motivazione.
Ed invece, la Suprema Corte, con un radicale mutamento rispetto alle precedenti uniformi decisioni, con l’ordinanza del 20 luglio 2020 – e senza, però, l’esplicitazione, nel suo percorso motivazionale, di quel rigore logico-sistematico che questo mutamento avrebbe meritato – richiamando le diverse conclusioni cui era pervenuta la CGE con la sentenza Pujante Rivera, e, segnatamente, la risposta alla terza questione posta dal giudice del rinvio, ha affermato il principio secondo cui “alla luce della corretta interpretazione della normativa comunitaria, nel numero minimo di 5 licenziamenti – in presenza del quale deve essere attivata la procedura di cui all’art.24 – rientra nella nozione di licenziamento il fatto che un datore di lavoro proceda unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del rapporto di lavoro per ragioni non inerenti la persona del lavoratore, da cui consegue la cessazione del rapporto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore stesso”.
Così, dunque, anche la nostra Suprema Corte, recependo il dichiarato intento della Direttiva di rafforzare la tutela dei lavoratori in ipotesi di licenziamenti collettivi, ha interpretato estensivamente la nozione di “licenziamento”, sino a farvi rientrare i c.d. “licenziamenti indiretti”, intanto sussistenti in quanto risultino integrati tre requisiti:
- che la cessazione del rapporto di lavoro sia da ascrivere a “ragioni non inerenti alla persona del lavoratore”;
- che la medesima cessazione sia voluta e disposta “unilateralmente” dal datore di lavoro;
- che la modifica concerna un “elemento essenziale del contratto di lavoro”.
Ora, però, al fine di cogliere appieno la chiave interpretativa unitaria della nozione di licenziamento collettivo, appare necessario esaminare anche l’interpretazione del comma 2° dello stesso art. 1, par.1, della Direttiva, così come data dalla CGE non solo in seno alla sentenza Pujante Rivera – secondo quesito del giudice remittente – ma, più chiaramente, alla successiva sentenza Ciupa, in causa C-429/16 del 21 settembre 2017, allorché veniva esaminata la fattispecie di una lavoratrice polacca alla quale era stata temporaneamente ridotta la retribuzione in misura pari al 15%, in ragione della notifica di “un avviso di modifica, avente ad oggetto la revisione delle condizioni di lavoro e salariali delle spese per il personale dettata dalla difficile situazione finanziaria” (p. 16); dalla mancata accettazione della lavoratrice di detta modifica, era seguita la risoluzione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia, in questa ultima fattispecie, aveva ritenuto che “il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica non sostanziale di uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro … o a una modifica sostanziale di un elemento non essenziale di detto contratto…non può essere qualificato come <licenziamento> ai sensi della citata direttiva” (p.28) ”. Più esplicitamente, aveva statuito che, seppur non potesse contestarsi “che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del rapporto di lavoro e che una riduzione del 15% di questa potrebbe, in linea di principio, essere qualificata come <modifica sostanziale>, ciò non toglie che il carattere temporaneo di tale riduzione diminuisce sensibilmente la portata della modifica del contratto” (p.29), per cui aveva concluso che tale modificazione poteva venire in rilievo al fine di configurare sì la fattispecie del licenziamento collettivo ai sensi del 2° comma dell’art. 1, par.1 della Direttiva, a condizione, però, che ci si trovasse già in presenza di almeno cinque licenziamenti, da intendersi quali risoluzioni in senso tecnico, poste in essere dal datore di lavoro o determinate, comunque, da una sua modificazione unilaterale e coinvolgente uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
In termini più espliciti, la Corte di Giustizia distingue tra
licenziamenti e cessazioni del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore e precisa che anche delle modifiche non sostanziali di un elemento essenziale del rapporto, ovvero delle modifiche sostanziali ad elementi non essenziali, da cui derivi pure la risoluzione del rapporto, sarà necessario tenere conto ai fini della tutela apprestata dalla procedura di cui al licenziamento collettivo, con il susseguente loro assoggettamento alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta, a condizione, tuttavia, che vi siano già almeno cinque licenziamenti formali, ancorché qualificati come tali in ragione di modificazioni sostanziali del rapporto di lavoro, nel senso di cui al 1° comma dell’art. 1 della direttiva.
Solo se lette insieme, le due decisioni, ci forniscono una chiave interpretativa unitaria e vincolante della nozione di licenziamento, differenziando tra licenziamento in senso tecnico, rilevante ai fini della sussistenza del requisito numerico di cui al comma 1, e cessazioni del rapporto ad esso assimilabili, di cui al comma 2, ai fini della tutela apprestata dalla legge.
Ma, aldilà di questa generalizzata enunciazione di principi, e tentando di rimanere ancorati ad un piano più strettamente pragmatico, vi è da chiedersi se debbano oggi ricomprendersi nella nozione di licenziamento, utile al fine di configurare la fattispecie licenziamento collettivo, altre ipotesi risolutorie, quali, esemplificativamente, le dimissioni incentivate, le risoluzioni consensuali, gli accordi per accedere al prepensionamento [4].
Orbene, la risposta al quesito potrebbe non avere carattere generale né essere univoca e tanmeno temporalmente intangibile in quanto spetterà al giudice nazionale il difficile compito di verificare, di volta in volta, il contenuto ed il significato da attribuire alla nozione di “modifiche sostanziali”, anche per il tramite ed il rimando a due canoni interpretativi generali [5]:
- da un lato il principio pacta sunt servanda, richiamato
anche dalla stessa sentenza Pujante Rivera, che sancisce
l’intangibilità del vincolo contrattuale al fine di conferire stabilità all’assetto delle reciproche obbligazioni;
- lo speculare rebus sic stantibus è il secondo fondamentale canone interpretativo di ausilio, rinvenibile nella relazione tematica n. 56/2020 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, che si è misurata sul bilanciamento tra i due principi, quello appena dianzi enunciato – che consente, a determinate condizioni, una revisione delle clausole contrattuali – e quello di vincolatività del sinallagma.
Nella relazione si legge che “(…) ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale, la parte danneggiata deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto della prestazione”.
E, certamente, il rinvio al più generale canone di buona fede e correttezza espresso dagli artt. 1366 e 1375 c.c. potrebbe operare il necessario coordinamento tra questi due principi apparentemente antitetici, ed il perno attorno a cui far ruotare la grande varietà di casistiche che è già stata portata e che continuerà, ancora, ad essere portata all’attenzione dei nostri giudici, nella consapevolezza che, non sempre e comunque, un trasferimento ovvero una riduzione della retribuzione integrano una modifica peggiorativa del contenuto del rapporto di lavoro e, comunque, nella analoga consapevolezza che l’esercizio, anche legittimo, dello ius variandi datoriale, può determinare modifiche così pregnanti da rendere sostanzialmente impossibile, per il lavoratore, proseguirne l’esecuzione.
Ciò che comporterà ovvie conseguenze non solamente, come appena rilevato, ai fini della configurazione dei licenziamenti indiretti nell’ambito della macroarea di quelli collettivi, ma anche ai diversi fini dell’individuazione delle ipotesi di riconoscimento del diritto del lavoratore al percepimento della NASpI allorché, esemplificativamente, incorra in una situazione di disoccupazione involontaria sempre a cagione delle nuove deteriori condizioni lavorative causate da fattori estranei alla sua volontà e responsabilità, ma imposte unilateralmente dal datore di lavoro e che non consentono la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto lavorativo.
E, in effetti, l’INPS, già con l’interpello n. 369/2018, aveva anticipato, di ben due anni, la soluzione innovativa della Suprema Corte (n.15401/2020) sopra commentata, allorché aveva ribadito che la volontà del lavoratore che si determina alla risoluzione consensuale – dopo il suo rifiuto al trasferimento ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla sua residenza – poteva essere stata indotta dalle notevoli e deteriori variazioni delle primigenie condizioni di lavoro.
In un’ipotesi di tal fatta, per dirla con l’Istituto previdenziale, la risoluzione consensuale in questione non muta il titolo della cessazione del rapporto di lavoro, che resta atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro e che dà, dunque, diritto al lavoratore di percepire la relativa indennità di disoccupazione.
Da ultimo, e per concludere, nella successiva Circolare INPS n. 40/2020 – che fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali si configura, in capo a parte datoriale, l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, ai sensi dell’art. 2 L. Fornero n. 92/2012 – questo concetto viene ulteriormente esplicitato e la recentissima sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze, del 02.10.2023 n.258, su una fattispecie concernente il diniego dell’INPS a riconoscere la NASpI, conferma, ancora una volta, questo orientamento, da ritenere, quantomeno al momento, acquisito al nostro patrimonio giuridico.
Almeno sino alla prossima pronuncia di segno contrario…
NOTE BIBLIOGRAFICHE
- David Fracchia I confini tra risoluzione consensuale e recesso divengono incerti in Nuovo not. giur. 2020, n.2. ↑
- Francesco Rossi I licenziamenti collettivi: identificazione della fattispecie e ambito di applicazione dei criteri di scelta. ↑
- Vincenzo Antonio Poso, Labor, Il lavoro nel diritto – 03 agosto 2020. ↑
- Francesco Rossi, cit.. ↑
- Roberto Cosio, UE Internazionale, Il licenziamento indiretto nell’ordinamento complesso, 13.01.2023. ↑